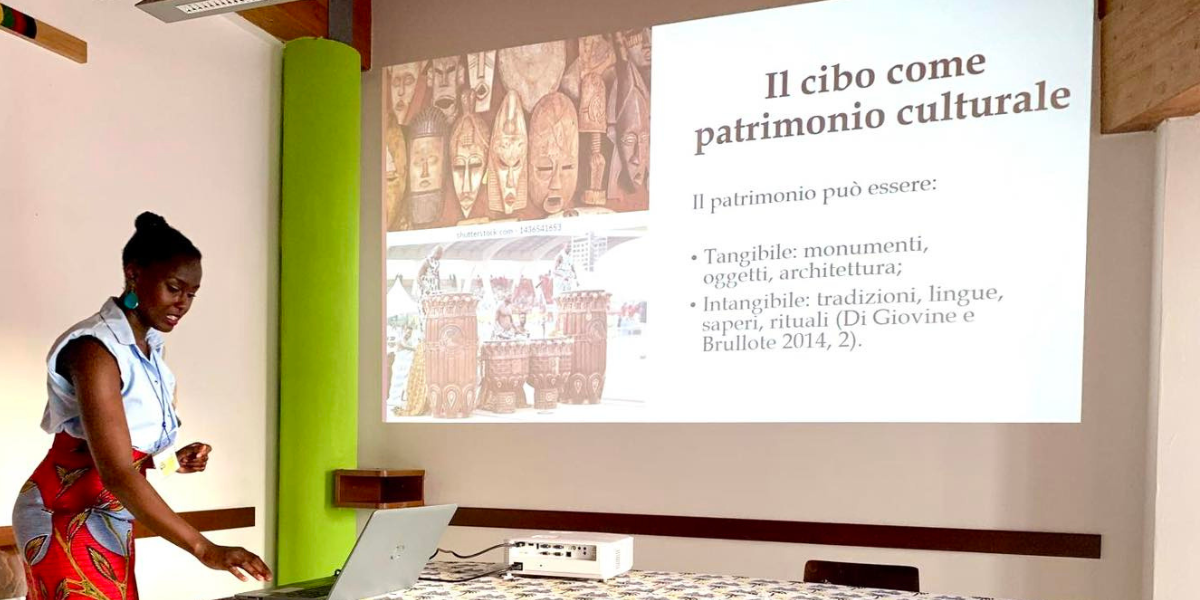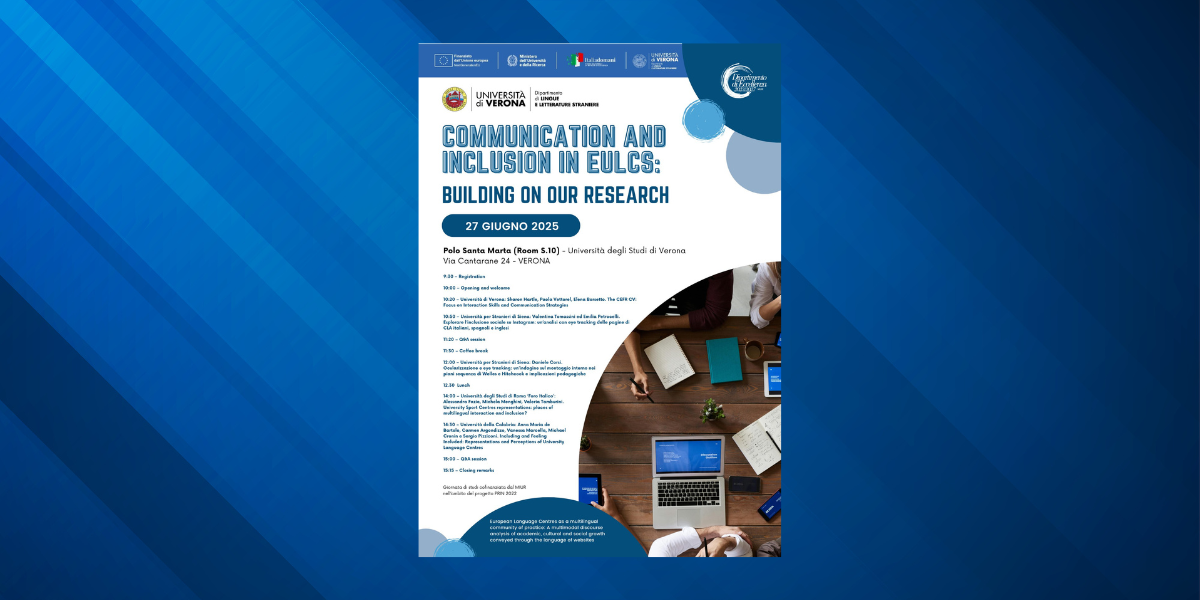Quante volte ci siamo fermati a riflettere su come le donne, in particolare quelle che vivono in paesi in guerra o sotto i riflettori internazionali, vengono percepite e descritte? Oggi, in particolare, l’attenzione si sposta sulle donne ucraine: sono madri premurose o streghe spietate? E qual è la verità dietro queste etichette?
Per esplorare queste complesse sfaccettature, nel diciassettesimo episodio di Inclusioni – il canale podcast del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona – abbiamo con noi Oksana Kis, storica e antropologa femminista, presidente della Ukrainian Association for Research in Women’s History, a Verona per il ciclo di seminari ЇЇ – Her: Dimensions of Ukrainian Womanhood.
L’intervista, condotta in inglese da Daniele Artoni, professore di slavistica presso il nostro dipartimento, ci guiderà attraverso le variegate dimensioni della femminilità ucraina.