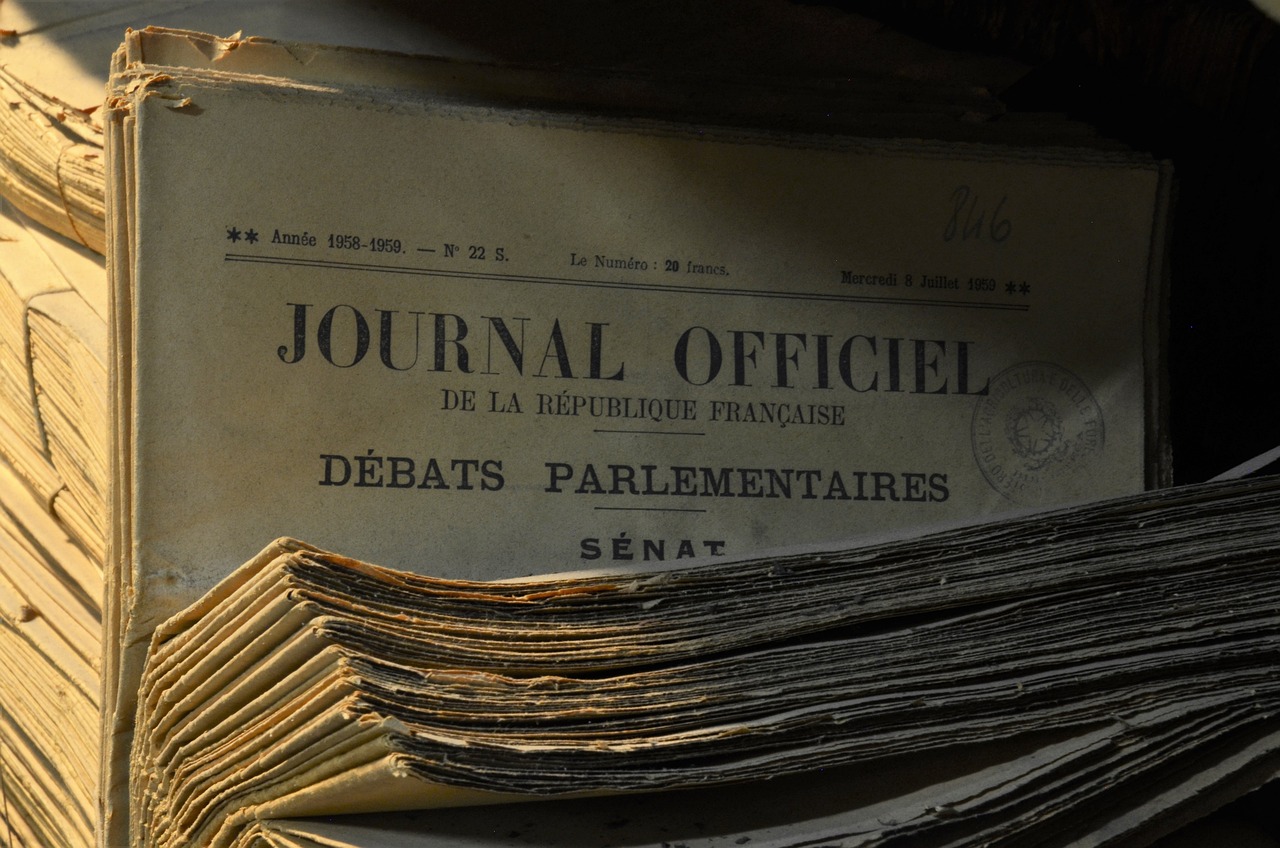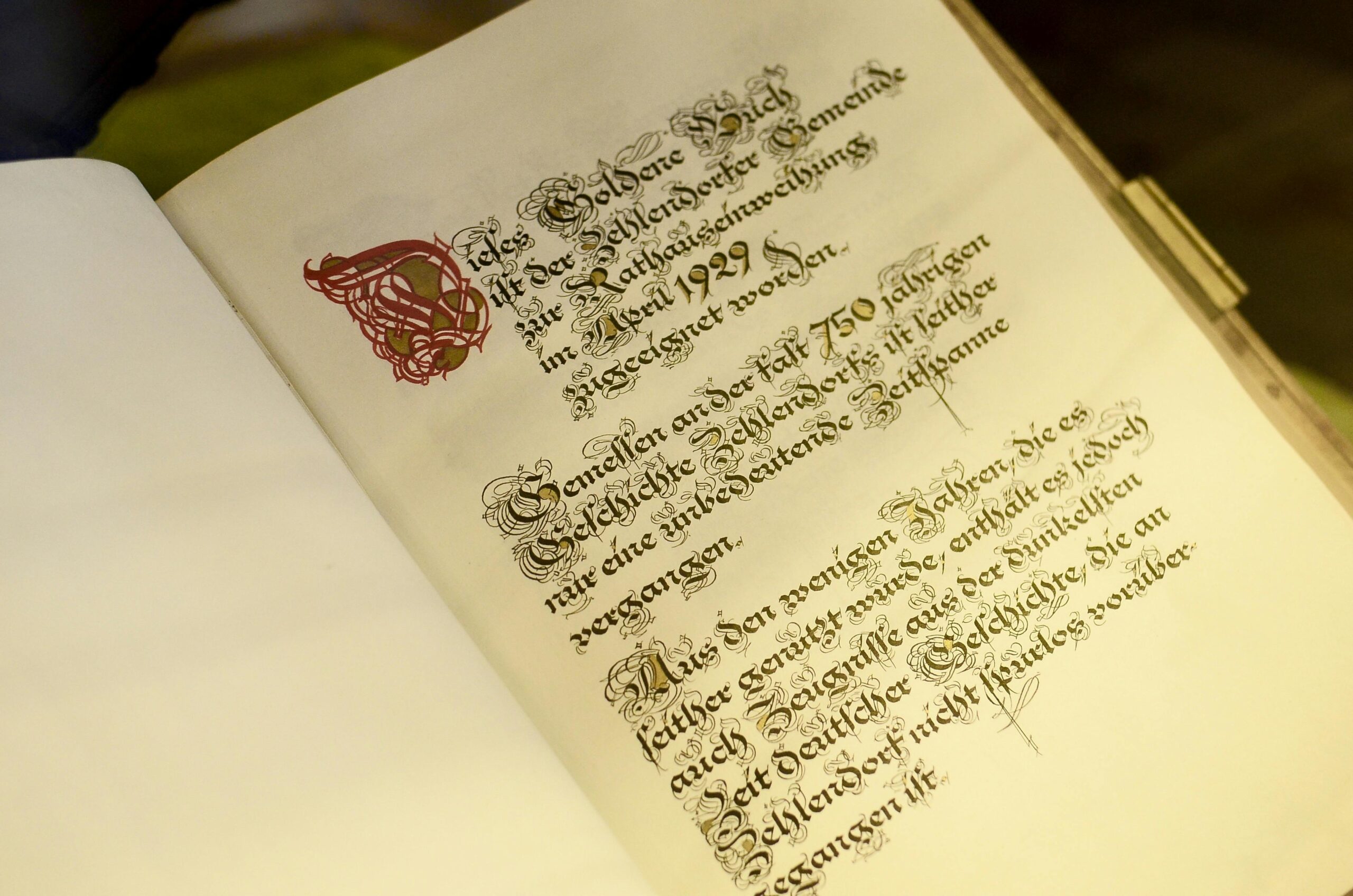- “Rossijskij Featr – Fonti musicali dell’Impero Russo, 1730-1836”: elaborazione di un archivio digitale open-access contenenti le fonti musicali primarie che attestano l’attività operistica;
- Il “Fondo russo” alla Biblioteca del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma: classificazione, digitalizzazione e selezione di titoli specifici per la pubblicazione in forma di edizione critica o documentaria;
- “14×14”: ricostruzione scientifica ed elaborazione di una risorsa multimediale per la divulgazione dell’esperienza del grand tour dei “conti del Nord”, il granduca Pavel Petrovič Romanov e la consorte Marija Fëdorovna – negli anni 1781-82;
- Progetto Šeremetev: publicazione della corrispondenza Hivart – Šeremetev in originale franco-russo, con traduzione inglese;
- Lo sventurato cavaliere Kosometovič: edizione documentarie dell’opera Gorebogatyr’ Kosometovič di Caterina II e Vicente Martín y Soler (1788-89).
-
Matteo Lissandrini (Professore associato di informatica)
-
Anna Stetsenko (assegnista)
-
Sofia Cappelletti (Bologna, Scuola di specializzazione in Beni musicali – Tirocinante atl Dip. Lingue e letterature Straniere UniVR)
- Roberto Giuliani, Luca Cianfoni, Francesca Candeli (Roma, Biblioteca del Conservatorio “Santa Cecilia”)
- Bella Brover-Lubovsky (Jerusalem Academy of Music and Dance)
- John A. Rice (independent researcher)
- Inna Naroditskaya (Northwestern University -Northwestern Bienen School of Music)
Giust, Anna, “When Music Suits Diplomacy: the grand tour of Pavel Petrovich Romanov, 1781–1782”, Cadernos de Queluz, Diplomacy and Aristocracy as Patrons of Music and Theatre in Europe of the Ancien Régime, a cura di I. Yordanova e F. Cotticelli, Hollitzer Verlag, Wien 2019, pp. 63-92
Giust, Anna, “International Networking in Russian Music Theatre around 1800: Sheremetev, Yusupov and Grand Duke Pavel Petrovich”, Nineteenth-Century Music Review, vol. 20/2 (2022), pp. 261-284 (DOI: https://doi.org/10.1017/S1479409822000131)